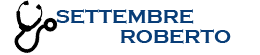La malattia di Alzheimer è un tipo di demenza molto frequente in tutto il mondo, in quanto colpisce oltre 5 milioni di persone negli Stati Uniti e circa mezzo milione di persone oltre i 60 anni di età in Italia.
La caratteristica clinica è una perdita progressiva della memoria recente che poi si associa ad un declino cognitivo con difficoltà nel parlare, nella comprensione della lingua, nel calcolo, nell’orientamento spazio-temporale e, a seguire, si ha persino un deterioramento delle funzioni sensoriali e motorie più semplici.
Inoltre, con la progressione della malattia, sopraggiungono sintomi comportamentali come deliri, agitazione, cambiamenti di personalità, e disturbi dell’umore con effetti devastanti sui pazienti ed i loro parenti. Attualmente,
le cure farmacologiche proposte non hanno dato i risultati sperati.
Dato il grande impatto socio-economico di questa malattia, numerosi gruppi di ricerca stanno studiando come poter affrontare e rallentare questa condizione patologica.
Un’équipe di ricercatori coordinati dal professor Marcello D’Amelio, associato di Fisiologia Umana e Neurofisiologia presso l’Università Campus Bio-Medico di Roma ha scoperto (pubblicando lo studio sulla rivista Nature Communications) che la morte cellulare nell’area del cervello che produce la dopamina (un neurotrasmettitore essenziale per alcuni importanti meccanismi di comunicazione tra i neuroni)) sarebbe la causa dell’Alzheimer.
 Infatti, un’accurata analisi morfologica dell’encefalo ha mostrato che quando vengono a mancare i neuroni dell’area tegmentale ventrale, che producono la dopamina, il mancato apporto di questo neurotrasmettitore provoca il malfunzionamento dell’ippocampo, generando la perdita di memoria.
Infatti, un’accurata analisi morfologica dell’encefalo ha mostrato che quando vengono a mancare i neuroni dell’area tegmentale ventrale, che producono la dopamina, il mancato apporto di questo neurotrasmettitore provoca il malfunzionamento dell’ippocampo, generando la perdita di memoria.
Per avere conferma di questa ipostesi si è fatto un esperimento somministrando in laboratorio, su modelli animali, due diverse terapie: una con L-Dopa, (un amminoacido precursore della dopamina), l’altra basata su un farmaco che ne inibisce la degradazione: si è registrato, in entrambi i casi, il recupero completo della memoria, in tempi relativamente rapidi.
Inoltre è stato rilevato l’interessamento nel rilascio della dopamina anche di un’altra importante area del cervello, chiamata nucleo accumbens, che controlla la gratificazione e i disturbi dell’umore, garantendone il buon funzionamento. Per cui, con la degenerazione dei neuroni che producono dopamina, aumenta anche il rischio di andare incontro a progressiva perdita di iniziativa, indice di un’alterazione patologica dell’umore, che effettivamente è frequente tanto nella Alzheimer quanto nel Parkinson.
Pertanto i cambiamenti nel tono dell’umore non andrebbero considerati, come si credeva fino ad oggi, una conseguenza della comparsa dell’Alzheimer, ma potrebbero rappresentare piuttosto una sorta di campanello d’allarme dietro il quale si nasconde l’inizio subdolo della patologia.
Alzheimer e Parkinson: non solo farmaci per la cura
Quindi, i risultati ottenuti suggeriscono di non sottovalutare i fenomeni depressivi nella diagnosi di Alzheimer, perché potrebbero andare di pari passo con la perdita della memoria.
 Infine, poiché anche il Parkinson è causato dalla morte dei neuroni che producono la dopamina, è possibile immaginare che le strategie terapeutiche future per entrambe le malattie potranno concentrarsi sulla battaglia contro la morte di questi neuroni.
Infine, poiché anche il Parkinson è causato dalla morte dei neuroni che producono la dopamina, è possibile immaginare che le strategie terapeutiche future per entrambe le malattie potranno concentrarsi sulla battaglia contro la morte di questi neuroni.
Tuttavia i farmaci che inibiscono la degradazione della dopamina si rivelano utili solo per alcuni pazienti, funzionando unicamente nelle fasi iniziali della malattia, quando ancora sopravvive un buon numero di neuroni dell’area tegmentale ventrale; con la morte di tutte le cellule di quest’area, la dopamina smette del tutto di essere prodotta e il farmaco, ovviamente, non è più efficace.
Né tantomeno la L-Dopa può essere data ai pazienti se non nelle ultime fasi della malattia perché, come emerso anche nei casi di Parkinson, provoca fenomeni di particolare tossicità che possono aggravare le loro condizioni.
A tal proposito può essere presa in considerazione la stimolazione cerebrale magnetica transcranica (TMS), risultata preziosa in ambito neurofisiologico e come trattamento di patologie psichiatriche e neurologiche.
Numerosi studi scientifici dimostrano l’efficacia di questa tecnica non solo nel potenziamento neuronale e nella depressione. Infatti, la TMS può rappresentare un mezzo affidabile per migliorare le funzioni cognitive e la memoria.
 Gli ambiti di utilizzo della TMS sono vari: inizialmente utilizzata come strumento d’indagine nelle neuroscienze cognitive e nello studio di varie funzioni neuropsicologiche, sono stati progressivamente sviluppati ambiti applicativi per il trattamento di alcune malattie neurologiche e neuropsichiatriche, come ad esempio, disturbi motori, epilessia, depressione e schizofrenia (Walsh & Cowey 2000). La modulazione a lungo termine che viene ottenuta con la stimolazione magnetica ripetitiva (rTMS) offre, infatti, la possibilità di un’applicazione terapeutica per normalizzare livelli di attività corticale che siano patologicamente bassi o eccessivamente alti in diversi processi patologici, come per esempio:
Gli ambiti di utilizzo della TMS sono vari: inizialmente utilizzata come strumento d’indagine nelle neuroscienze cognitive e nello studio di varie funzioni neuropsicologiche, sono stati progressivamente sviluppati ambiti applicativi per il trattamento di alcune malattie neurologiche e neuropsichiatriche, come ad esempio, disturbi motori, epilessia, depressione e schizofrenia (Walsh & Cowey 2000). La modulazione a lungo termine che viene ottenuta con la stimolazione magnetica ripetitiva (rTMS) offre, infatti, la possibilità di un’applicazione terapeutica per normalizzare livelli di attività corticale che siano patologicamente bassi o eccessivamente alti in diversi processi patologici, come per esempio:
- Esiti di ictus cerebrale (Alonso-Alonso et al. 2007)
- Tinnito (Kleinjung et al. 2007)
- Morbo di Parkinson (Cantello et al. 2002),
- Riduzione della frequenza di alcuni tic (Karp et al. 1997)
- Afasia di Broca (Kobayashi & Pascual-Leone 2003)
- Lesione del lobo parietale destro, con neglect (Oliveri et al. 2001)
- Schizofrenia (Hoffman et al., 1998; Nahasetal., 1999)
- Ansia (Greenberg & Rauch, 1999; Grisaru et al, 1998)
- Depressione (George et al., 1998; Nahas et al., 1998; Erantietal., 2007)
- Mania (Grisaru, etal., 1998)
- Alzheimer (Freitas et al. 2011).
 La possibilità di indurre cambiamenti nell’eccitabilità corticale che perdurano oltre il periodo di stimolazione sembra essere uno dei principali motivi che possono spiegare gli effetti ottenuti con i pazienti; questi cambiamenti duraturi dell’eccitabilità corticale dipendono da un numero elevato di variabili come la frequenza di stimolazione, l’intensità dello stimolo, il sito e il numero di applicazioni. Il “carico” totale di stimolazione (numero di stimoli/seduta/giorno, numero di sedute) sembra comunque essere un punto importante per la sua reale efficacia.
La possibilità di indurre cambiamenti nell’eccitabilità corticale che perdurano oltre il periodo di stimolazione sembra essere uno dei principali motivi che possono spiegare gli effetti ottenuti con i pazienti; questi cambiamenti duraturi dell’eccitabilità corticale dipendono da un numero elevato di variabili come la frequenza di stimolazione, l’intensità dello stimolo, il sito e il numero di applicazioni. Il “carico” totale di stimolazione (numero di stimoli/seduta/giorno, numero di sedute) sembra comunque essere un punto importante per la sua reale efficacia.
 Concludendo, in attesa che venga fornita qualche cura che abbia una reale utilità nella Malattia di Alzheimer, possiamo considerare la stimolazione magnetica transcranica un’ottima opportunità, sia per procrastinare l’inizio della malattia, sia per rallentarne l’evoluzione verso un inevitabile peggioramento clinico.
Concludendo, in attesa che venga fornita qualche cura che abbia una reale utilità nella Malattia di Alzheimer, possiamo considerare la stimolazione magnetica transcranica un’ottima opportunità, sia per procrastinare l’inizio della malattia, sia per rallentarne l’evoluzione verso un inevitabile peggioramento clinico.